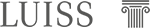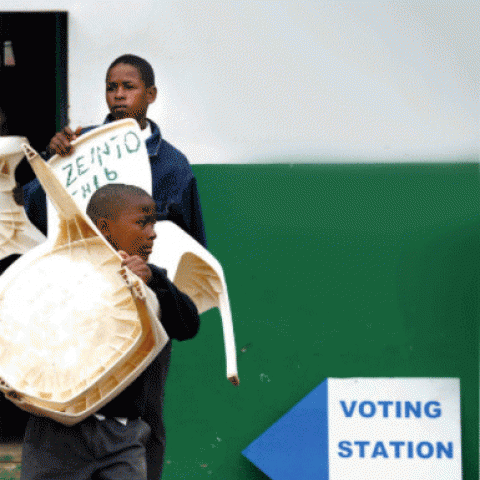Qual è l'impatto effettivo di una crisi economica su una democrazia contemporanea? Da questa domanda muove lo studio condotto dal Professor Leonardo Morlino, docente ordinario di Scienza politica e Prorettore alla Ricerca LUISS, e dal Professor Francesco Raniolo, direttore del Dipartimento di Scienze politiche e Sociali presso l'Università della Calabria. Edito da Palgrave, il libro The Impact of the Economic Crisis on South European Democracies si concentra sulle trasformazioni della democrazia e le conseguenze della crisi più recente nei quattro paesi dell'Europa meridionale (Grecia, Italia, Portogallo e Spagna).
"Sull'impatto delle crisi economiche nella storia della politica c'è una larga letteratura tradizionale" spiega il Professor Morlino. "Gli studi partono dalle analisi della crisi degli anni Venti, la cosiddetta crisi di Wall Street, quando ci sono stati anche crolli della democrazia, come nel caso della Germania di Weimar. Con le crisi successive, molti autori sostengono che l'impatto si sia ridotto e concentrato su proteste, mutamenti di voto e atteggiamenti più radicali, senza però mettere in discussione il regime democratico. Forse il risultato più importante della nostra ricerca è riscontrare che non è corretto sostenere che l'impatto sulle democrazie attuali è stato parziale. L'impatto vi è stato e anche notevole, ma si è concentrato nei paesi nei quali esistevano già le condizioni politiche di incertezza e instabilità che potevano predisporre al mutamento. Parliamo a questo proposito di un impatto catalizzatore: la crisi ha inciso su un quadro complessivo di condizioni e ha accelerato e reso più netti i risultati attuali".
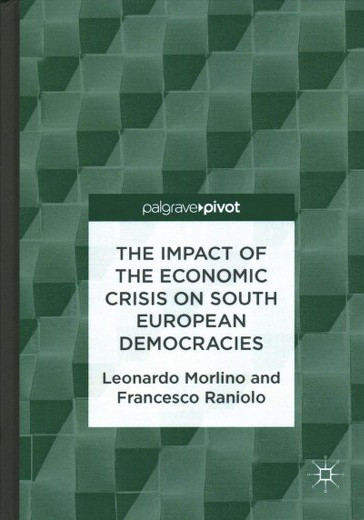 Rispetto alla crisi degli anni Settanta e Ottanta, questa iniziata nel 2007, soprattutto negli Stati Uniti d'America, e proseguita nel 2008 in Europa, ha visto cambiare sostanzialmente il ruolo dei gruppi di interesse e la maggiore radicalizzazione dello scenario politico. "Negli ultimi anni il ruolo crescente delle istituzioni europee ha ridimensionato il peso delle associazioni sindacali e dei gruppi industriali nelle politiche interne. Allo stesso modo, il conflitto destra-sinistra si è indebolito con l'emergere di partiti di protesta che si propongono di superare questa divisione classica. Ma ciascuno di questi nuovi fenomeni è l'effetto di un'accelerazione/trasformazione di elementi già esistenti, molto legati al contesto e alle tradizioni di ciascun paese".
Rispetto alla crisi degli anni Settanta e Ottanta, questa iniziata nel 2007, soprattutto negli Stati Uniti d'America, e proseguita nel 2008 in Europa, ha visto cambiare sostanzialmente il ruolo dei gruppi di interesse e la maggiore radicalizzazione dello scenario politico. "Negli ultimi anni il ruolo crescente delle istituzioni europee ha ridimensionato il peso delle associazioni sindacali e dei gruppi industriali nelle politiche interne. Allo stesso modo, il conflitto destra-sinistra si è indebolito con l'emergere di partiti di protesta che si propongono di superare questa divisione classica. Ma ciascuno di questi nuovi fenomeni è l'effetto di un'accelerazione/trasformazione di elementi già esistenti, molto legati al contesto e alle tradizioni di ciascun paese".
Le differenze tra i paesi dell'Europa meridionale e il resto d'Europa riguardano soprattutto la funzione dei partiti e la strutturazione del sistema partitico. Tra le varie conseguenze, la crisi prima di tutto ha comportato l'evoluzione dei movimenti di protesta in partiti politici veri e propri. "Rispetto alla Germania, dove gli effetti della crisi sono stati risolti compattando in una grande alleanza i principali partiti tradizionali, nei paesi presi in esame, ad esempio la Grecia, ideologie e movimenti di protesta si sono a poco a poco istituzionalizzati e hanno messo in crisi il modello di democrazia di tipo clientelare. Il partito organizzato è scomparso e l'incertezza economica ha rilanciato nuovi partiti di tipo leaderistico nati dalle proteste".
"In tutti i paesi sudeuropei vi è stata un'evoluzione dei movimenti sociali in partiti istituzionalizzati – prosegue Morlino su questo argomento - anche se in ogni paese questo è avvenuto in modo diverso. In Spagna, Podemos è il risultato dell'evoluzione di movimenti sociali nati nella società civile; in Grecia, ancora sulla spinta dei movimenti di protesta Syriza si è formato aggregando piccoli gruppi partitici già esistenti, ma frammentati; in Italia, appena è emersa la possibilità di sviluppare dei movimenti sociali è stato subito creato da Grillo e Casaleggio il M5S che ha subito svolto un ruolo di integrazione negativa (come diceva Günther Roth) istituzionalizzando la protesta. In Portogallo vi è stato il risultato più paradossale: di fronte a un'alienazione dalla politica molto accentuata la conseguenza è stata l'insuccesso dei partiti di protesta e, di conseguenza, la sopravvivenza dei partiti tradizionali".
La crisi ha comportato anche una radicalizzazione del linguaggio politico. Questo radicalismo è stato talvolta di stile e di facciata più che effettivo e, dunque, tradotto in posizioni politiche estremiste. Si è anche sviluppata una retorica secondo la quale le innovazione informatiche avrebbero posto le basi per realizzare la democrazia diretta. "Non è stato così. Oggi i partiti non sono più organi di rappresentanza ma sono diventati attori particolarmente rilevanti nella formazione delle opinioni e nell'influenzare il voto. Il fatto è che anche nell'epoca digitale qualcuno deve elaborare e porsi come intermediario rispetto alle decisioni politiche da prendere. Rimettere al voto dei cittadini online una certa questione e degli esiti decisi da altri non è democrazia diretta, ma nel migliore dei casi formazione di consenso e nel peggiore, più frequente, manipolazione dell'opinione pubblica".
Nel momento in cui un linguaggio radicalizzato diventa dominante, la tendenza alla bipolarizzazione delle democrazie contemporanee viene meno e, secondo l'analisi dei due docenti, avviene una sorta di tripolarizzazione delle intenzioni di voto che cambia un aspetto di fondo della democrazia. "La democrazia è basata sull'idea che il cittadino possa giudicare e punire il politico per il suo comportamento, ma questo meccanismo può essere fortemente indebolito da alleanze che tra élite partitiche minoritarie contro un terzo polo relativamente maggioritario. In Spagna e in Italia questa tendenza alla tripolarizzazione è molto forte. Ma se nel caso spagnolo la legge elettorale favorisce i partiti che ottengono il maggior numero di voti, in Italia l'attuale assetto proporzionale creerà maggiore incertezza e confusione e, nel migliore dei casi, finirà con il dare un ruolo preponderante dell'Unione Europea nella formazione delle politiche".
"La rabbia e la protesta non sono sempre pericolose" conclude il Professor Morlino. "La rabbia non violenta è positiva per le democrazie attuali perché spinge i governi a essere più ricettivi rispetto alle richieste degli elettori. Però ci vogliono istituzioni in grado di essere tali, mentre le istituzioni proporzionali sono meno ricettive perché più deboli e incerte nella loro capacità decisionale e, più in generale, di governo".