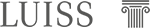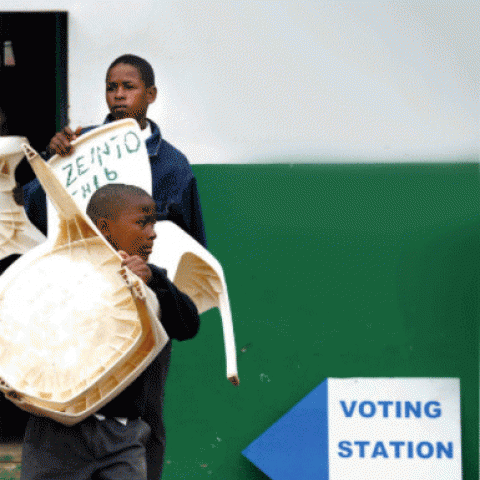"È possibile dare giudizi morali sulla condotta dei politici, anche se ciò non vuol dire che la politica si riduca alla morale, o vi sia subordinata". Etica pubblica, il lavoro più recente del docente LUISS Gianfranco Pellegrino, affronta il tema della questione morale in politica attraverso un punto di vista storico e filosofico che cerca di superare sia le trappole del moralismo che quelle del realismo politico.
Pubblicato da LUISS University Press nella collana "Piccole Introduzioni", il libro del professore di Filosofia politica riflette sui confini fra etica e politica discutendo eventi della storia italiana recente, dal rapimento di Aldo Moro a Tangentopoli.
"Ci sono ragioni specificamente politiche a favore di certi comportamenti, ma ci possono essere ragioni specificamente morali contro questi medesimi comportamenti – sostiene il Professor Pellegrino. Allo stesso tempo, ci sono ragioni morali che valgono in maniera più forte per i politici, come l'imparzialità, e ragioni che valgono in maniera attenuata per chi fa politica, come l'affetto filiale. L'etica pubblica è l'idea che le ragioni morali non vengano ridotte al silenzio dalle ragioni politiche, ma che queste ragioni contino quanto le ragioni politiche e che possano suscitare nei cittadini comportamenti elettorali e pratici di ripulsa per certi politici".
In questo senso, la sua analisi fornisce una lettura alternativa della storia italiana recente: "Secondo alcuni, le vicende politiche del nostro paese, almeno a partire dalla fine degli anni Settanta e soprattutto negli anni Novanta, sono state caratterizzate dall'antipolitica, cioè da un atteggiamento di critica della politica come professione che spesso dava voce a giudizi morali nei confronti dei politici. Secondo altri, invece, caratteristica centrale dall'immediato dopoguerra fino alla caduta del Muro è stata l'impossibilità per i partiti estremisti e anti-sistema, come il PCI e l'MSI, di andare al governo. Secondo me, a queste chiavi di lettura va aggiunto anche un disaccordo profondo che ha diviso gli italiani e che riguarda appunto l'idea, da alcuni adottata e da altri rifiutata, di etica pubblica".
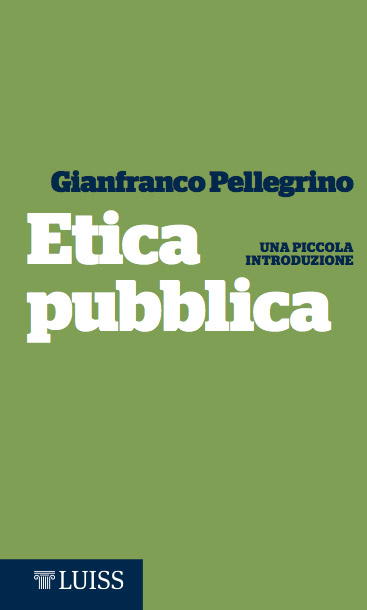 Pellegrino ripercorre la discussione pubblica italiana, prendendo a esempio le posizioni di intellettuali come Italo Calvino, Leonardo Sciascia e Alberto Arbasino, e difendendo l'idea che l'etica pubblica sia un fondamento della legittimità democratica. "Nessuno vuol essere costretto a compiere o permettere azioni che reputa immorali, ma dal momento che in democrazia ognuno è responsabile delle azioni dei suoi governanti (nel senso che le permette, o contribuisce a che vengano compiute), i cittadini possono vedere come illegittimi governanti che si siano macchiati di comportamenti immorali".
Pellegrino ripercorre la discussione pubblica italiana, prendendo a esempio le posizioni di intellettuali come Italo Calvino, Leonardo Sciascia e Alberto Arbasino, e difendendo l'idea che l'etica pubblica sia un fondamento della legittimità democratica. "Nessuno vuol essere costretto a compiere o permettere azioni che reputa immorali, ma dal momento che in democrazia ognuno è responsabile delle azioni dei suoi governanti (nel senso che le permette, o contribuisce a che vengano compiute), i cittadini possono vedere come illegittimi governanti che si siano macchiati di comportamenti immorali".
Per questo, secondo Pellegrino, l'etica pubblica è indipendente dallo schieramento politico ed è normale che influenzi l'approvazione dei cittadini. "I giudizi morali, alla lunga, possono determinare il comportamento elettorale, anche se non è detto che possano annullare del tutto altri fattori più determinanti a spostare il voto. È in questo senso che l'etica pubblica non è solo un ingrediente, ma è un fondamento della democrazia".