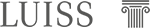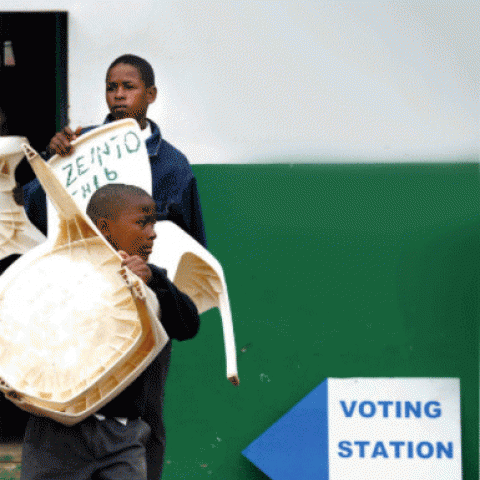Asylum Law in the European Union esamina la normativa internazionale ed europea sulla protezione internazionale dei richiedenti asilo. Scritto da Francesco Cherubini, docente LUISS di Organizzazione internazionale e diritti umani, e pubblicato da Routledge, il libro si concentra sull'evoluzione della prassi relativa alla figura del richiedente asilo a partire dal primo trattato internazionale elaborato in materia, la Convenzione di Ginevra del 1951, passando per la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, fino alle norme contenute nel primo e nel secondo pacchetto asilo.
La Convenzione di Ginevra, oltre a dare una definizione di rifugiato, stabilisce anche differenti diritti per le persone che rispondono a questa condizione. Dice Cherubini: "Alcuni diritti fondamentali, come il divieto di refoulement che impedisce di respingere le persone verso il paese nel quale rischiano di essere perseguitate, vengono garantiti a prescindere dalle modalità con cui sono fuggiti. Poi ci sono altri diritti che vengono estesi in base alla solidità della presenza del rifugiato nel territorio".
Il problema è che la figura del rifugiato resta ancora oggi molto ambigua per due motivi centrali: "il primo è che si basa su una Convenzione stipulata nel 1951 e modellata su misura dei movimenti migratori avvenuti all'interno dell'Europa durante la Seconda Guerra mondiale. Il secondo motivo, più importante, è che l'evoluzione interpretativa di queste norme necessiterebbe un organo internazionale capace di esercitare una forma di controllo e di garanzia sulle prassi dei singoli Stati".
Nel caso della protezione internazionale l'unico organo di controllo rinvenibile è l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), che però non ha un potere vincolante sull'interpretazione delle norme della Convenzione e demanda al singolo paese l'attribuzione dello status di rifugiato, con la conseguenza di avere alla fine risultati molto differenti da paese a paese.
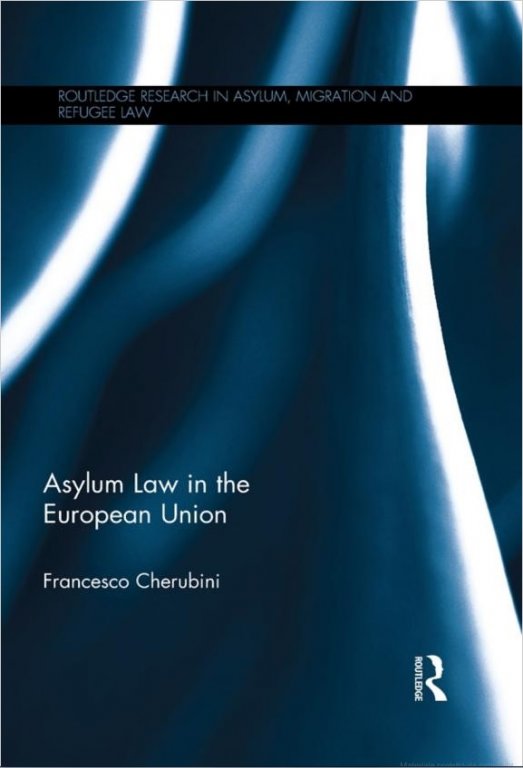 Ricostruendo la storia delle normative europee sulla protezione internazionale, Cherubini fa risalire la regolamentazione dell'Unione Europea a partire dal 1984, quando inizia a prendere piede l'idea di abolire i controlli alle frontiere interne e di realizzare il completamento del mercato interno. "Abolire i controlli alle frontiere interne significava, come è stato detto dal primo Presidente del comitato esecutivo della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, 'spostare i controlli dalla porta dell'appartamento a quella dell'immobile', ovvero dotarsi di una politica di immigrazione quantomeno armonizzata, che l'Unione Europea ha iniziato a produrre dopo le modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam".
Ricostruendo la storia delle normative europee sulla protezione internazionale, Cherubini fa risalire la regolamentazione dell'Unione Europea a partire dal 1984, quando inizia a prendere piede l'idea di abolire i controlli alle frontiere interne e di realizzare il completamento del mercato interno. "Abolire i controlli alle frontiere interne significava, come è stato detto dal primo Presidente del comitato esecutivo della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, 'spostare i controlli dalla porta dell'appartamento a quella dell'immobile', ovvero dotarsi di una politica di immigrazione quantomeno armonizzata, che l'Unione Europea ha iniziato a produrre dopo le modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam".
Un ruolo importante di garanzia e di interpretazione delle norme europee può svolgerlo la Corte di giustizia dell'Unione Europea. "Dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona queste norme sono state riconsegnate alla piena competenza della Corte di Giustizia, che ha potuto cominciare a emanare sentenze e che avrà un'incidenza sul miglioramento dell'armonizzazione, che è uno dei pilastri su cui si regge l'intero sistema normativo della protezione internazionale in Europa".
Questo sistema non ha ancora raggiunto un livello accettabile di armonizzazione: "uno dei capisaldi di questo sistema, il Regolamento Dublino II (ora III), serve a stabilire quale sia lo Stato responsabile a esaminare la domanda di riconoscimento dello status di protezione internazionale. Ci sono vari criteri per stabilire questa responsabilità, ma il problema è che distribuire le persone in base a questi criteri richiede che le condizioni e le possibilità di accoglienza siano più omogenee possibile. E invece non è così: i dati relativi all'accoglimento delle domande nel 2010 vanno da una percentuale di successo del 2% (Irlanda) e del 3% (Grecia) al 61% della Finlandia e al 100% del Portogallo".
Il dato emergente dall'analisi proposta dal libro è, in conclusione, proprio questo: i dati consegnano un sistema disomogeneo, al quale l'opera della Corte di giustizia può ovviare solo in parte. Alcune delle proposte enunciate nell'ultima parte del libro rappresentano quel tipo di riforme più radicali di cui il sistema avrebbe bisogno.