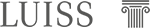L’articolo oggetto di questa intervista tratta della dottrina della cosiddetta “non delegabilità”: che cosa è la “dottrina Meroni” e perché è stata stabilita?
La dottrina della cd. “non delegabilità” è la teoria secondo cui gli organi costituzionali non possono delegare poteri costituzionalmente garantiti ad altri soggetti, abdicando quindi alla loro funzione pubblica. Nel diritto dell’Unione Europea tale dottrina è stata sviluppata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia come principio di equilibrio istituzionale che favorisce il bilanciamento tra poteri pubblici europei nell’ambito del sistema dell’ordinamento europeo: in assenza di un principio di separazione dei poteri – come esiste invece nei singoli stati membri – questo principio ha consentito di preservare i poteri che le singole istituzioni europee detengono sulla base del principio di attribuzione dei poteri stabilito nei Trattati. Il principio di “non delegabilità” riguarda quindi tutte le istituzioni europee ed assicura che nessuna istituzione possa interferire nel’’esercizio dei poteri da parte delle altre istituzioni.
Questo non significa che non sia possibile delegare alcuni poteri, ma piuttosto che esistono precisi limiti alla capacità di delegarli. In particolare, per quanto riguarda i poteri delle agenzie europee, il tema dei limiti della delega è stato originariamente sviluppato nel caso Meroni c. Alta Autorità, una sentenza della Corte di Giustizia che risale al 1958, ai tempi della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio: l’Alta Autorità aveva delegato a due agenzie di diritto belga (le cd. agenzie di Bruxelles) la responsabilità del funzionamento del meccanismo finanziario per il regolare rifornimento di rottame nel mercato comune, con conseguente “fuoriuscita dei poteri” rispetto alle responsabilità dell’Alta Autorità nell’ambito del Trattato CECA. La conclusione della Corte di giustizia fu che la delega fosse legittima soltanto a determinate condizioni, che escludessero un’attribuzione non democratica di poteri normativi a soggetti privi di legittimazione democratica e di un solido fondamento giuridico nei Trattati. In particolare, il caso Meroni ha sanzionato l’attribuzione alle agenzie di Bruxelles di poteri discrezionali talmente ampi da comportare l’abdicazione sostanziale dei compiti delle autorità investite dai Trattati.